
SCHEDA INFORMATIVA A CURA DI ARCHEMAIL
Alcuni ritrovamenti di
oggetti di selce testimoniati da eruditi del Settecento, ci inducono a
pensare ad uno stanziamento preistorico sulla collina della Civitella, sulla
quale sono state individuate tracce di un'ara sacrificale e vi è ancora ben
visibile una vasca lustrale e alcuni ripari sotto roccia.
Tale presenza che comunemente viene detta "enotria", ascrivibile all'età del
bronzo, si spiega con la vicinanza del passo "Alfa" che da Cannalonga segue
le pendici nord del monte Gelbison per raggiungere la valle del Calore e di
qui il Vallo di Diano: via battuta da tempi immemorabili. Altrettanto
antichi sono i luoghi di culto del Gelbison e della Civitella, accomunati da
leggende che il popolo ancora tramanda.
Sulle pendici della sopraddetta collina sono stati rinvenuti materiali di
epoca greco-lucana e soprattutto dopo gli scavi del 1966 si ci è trovati di
fronte ad un vero e proprio insediamento del IV secolo a.C., sostenuto e
difeso da poderose mura che appaiono essere di terrazzamento, ma che
certamente svolgevano funzione difensiva. Forse si tratta di un avamposto
fortificato (frurion) di Velia per il controllo del passo "Alfa". E poco,
probabilmente, potranno dire ulteriori scavi se si pensa che le abitazioni
più antiche di Moio e la stessa chiesa di Santa Veneranda sono state
costruite con materiale di recupero dell'insediamento della Civitella.
Di Moio come centro abitato si ha una prima notizia documentata nel 1052.
Uno dei siti
archeologici più suggestivi del Cilento interno è, certamente, quello
ubicato sulla Civitella, protetto dal fresco ombroso di un fitto e
rigoglioso castagneto.
La collina della Civitella (818 m. s.l.m.) occupa una posizione strategica
di controllo di tutta la viabilità naturale tra le zone interne montuose e
lo sbocco al mare. Alle pendici del colle, sul versante meridionale, si apre
il valico verso Cannalonga che conduce agli Alburni e da qui al Vallo di
Diano; l'altro versante domina il corso del Badolato e quindi la viabilità
verso Velia.
La posizione dominante, la presenza dei corsi d'acqua e delle sorgenti, le
terrazze pianeggianti hanno favorito l'impianto di un insediamento
articolato e complesso che, certamente, dal controllo delle direttrici di
traffico, ha ricavato ricchezza e potenza. La frequentazione del colle è
documentata dalla fine del VI sec. a.C., da alcuni frammenti ceramici
raccolti in superficie, ma è a partire dalla metà circa del IV sec. a.C. che
inizia la costruzione di una possente cinta fortificata, articolata in due
circuiti che racchiude il colle su tre lati; il lato a Nord è difeso
naturalmente dallo strapiombo della roccia.
La costruzione della cinta ha richiesto tempi lunghi e maestranze
specializzate; i blocchi di arenaria locale sono perfettamente tagliati e
squadrati e messi in opera a filari paralleli, conservati, in alcuni tratti
per un'altezza di 5/6 filari.
Delle diverse porte che consentivano l'accesso all'abitato, una in
particolare sul lato meridionale, si è conservata meglio.
La porta presenta un complesso sistema di difesa ed è costituita da un lungo
e stretto corridoio che accede ad un vano rettangolare che, a sua volta, si
restringe nel vero e proprio ingresso chiuso dalla porta di legno di cui
rimangono i cardini tagliati nella pietra e la traccia del battente.
La porta era coperta da un arco costruito con i blocchi squadrati tagliati,
su un lato, in curva, secondo una tecnica costruttiva largamente nota in
numerosi altri siti dell'Italia Meridionale.
Sul pianoro centrale del colle è stato esplorato, in piccolissima parte,
l'agglomerato di case, di cui si conosce ancora poco la planimetria e
l'organizzazione dei vani. Anche la scoperta di uno spiazzo scoperto,
basolato, non ha trovato ancora una valida spiegazione e solo
un'esplorazione più ampia potrà consentire una lettura complessiva
dell'abitato.
A breve distanza è stata individuata un'altra struttura, più complessa che,
la presenza di un deposito votivo, connota come un edificio di tipo
cultuale.
Il centro antico della Civitella, fiorente soprattutto tra IV e III sec. a.C.,
è abbandonato già alla fine del III sec. a.C. quando, con l'arrivo dei
Romani, si assiste alla scomparsa improvvisa degli insediamenti ed allo
spopolamento delle campagne.
Aperto ancora è il dibattito se queste fortificazioni sparse
nell'entro-terra di Velia siano una forma di difesa del territorio
organizzato della città greca o piuttosto rispondano, come sembrano
suggerire i dati della ricerca più recente, a quella forma di occupazione
capillare del territorio da parte dei Lucani, a partire dalla fine del V
sec. a.C. quando conquistano Poseidonia.
D'altro canto anche ad Elea, considerata un "baluardo della grecità" , non
mancano, soprattutto nella cultura materiale, segni evidenti di una
promiscuità con i Lucani che occupano, come si è visto, con fattorie sparse,
tutto il territorio lungo la valle del Badolato.
IMMAGINI DEL SITO
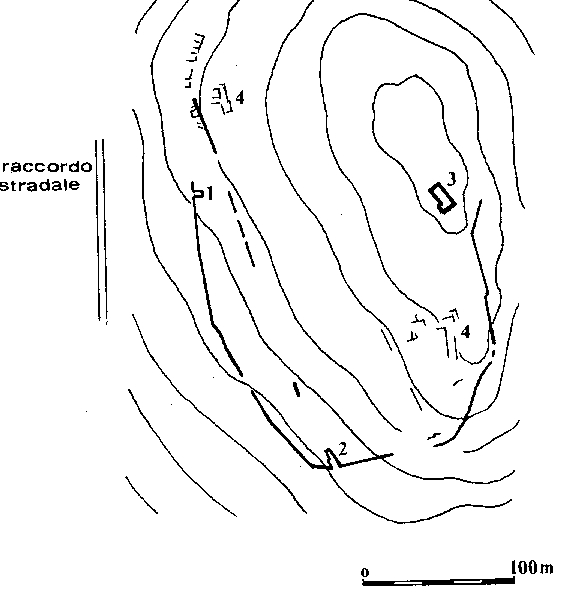
Non si assume alcuna responsabilità per eventuali difformità da quanto riportato in questa pagina